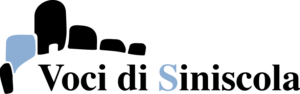DI CHI E’ L’OMBRA CHE PROIETTA IL MIO ALBERO?
C’è caldo, e questo a prescindere dalle cicale che Pinco pure sente.
Boccheggiante confida nel parcheggio su strada davanti al suo civico per correre in cucina a bere.
Ma lì, all’ombra delle fronde che sporgono dal suo giardino c’è una macchina e non è la sua.
Un martellante sillogismo fa ora ping pong fra la pancia e il cervello di Pinco:
L’ombra è dell’albero, l’albero è il mio, il parcheggio è mio.
C’è caldo, ha sete e qualcuno ha rubato la sua ombra.
Vi sarà capitato di vedere Pinco o di essere Pinco, magari alle prese con un’altra situazione, ma sempre fermamente convinto di essere nella ragione. E’ come se, quando si palesa un bisogno, ci sia un diritto che non contempla il merito.
Da qui la costruzione del nemico, che altri non è che l’ostacolo al soddisfacimento del bisogno personale, e della legittimazione di quel bisogno.
Ma quale sarà il ragionamento di Pinco in relazione allo spazzamento delle foglie cadute dal suo albero che fanno scivolare la signora Pallina?
Pinco dirà che non può controllare il vento, tantomeno l’arrivo della pioggia, e la signora Pallina poteva stare attenta, perché lo sanno tutti che le foglie bagnate sono scivolose. Pinco dirà sarcasticamente che non può addestrare l’albero a far cadere le foglie nel suo giardino, che paga per la pulizia delle strade e in maniera indiretta rinnegherà le foglie della “sua” ombra.
E se la risposta a questo domino di situazioni fosse parcheggiare dove c’è posto e spazzare di fronte a casa?
Se ragionata a rigor di metafora la questione dei parcheggi e della monetizzazione della gestione della cosa pubblica si rivelasse la cartina tornasole verso l’interpretazione di una libera volontà individuale?
Potrebbe sembrare una forzatura argomentare su questo tema partendo dal parcheggio dal momento che prima dell’arrivo delle automobili nemmeno esisteva come termine, ma non possiamo non constatare che sempre più frequentemente se ne parla in relazione a questo o quel problema come se fossero il perno su cui ruotano ragioni sociologiche, urbanistiche ed economiche.
Fino a quando i mezzi di locomozione erano i carri trainati dagli animali lo spazio per il loro ricovero, almeno in Sardegna, era garantito all’interno delle corti private, mentre ora, anche qualora le abitazioni fossero dotate di ricovero auto privato, la tendenza è il parcheggio su strada e la conseguente riconversione del garage a locale abitativo o di pertinenza diretta dell’abitazione.
Proviamo a ragionare su cosa abbia generato quest’inversione di tendenza.
Con il Decreto interministeriale n.1444 del 1968, lo stato italiano ha fissato i parametri a cui gli enti locali si devono attenere in fase di pianificazione urbanistica, stabilendo che, per ogni abitante insediato o di previsione, siano garantiti almeno “18 metri quadri per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie” (Art.3 D. Interministeriale n. 1444/68); Detta superficie è ridotta a 12,00 metri quadri nel caso di comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 20.000 abitanti, dei quali 2,50 sono destinati a parcheggio pubblico, distribuibili anche su diversi livelli.
In seguito, con la Legge n.122 del 1989, così detta Legge Tognoli, si è passati a disciplinare in materia di parcheggi privati, stabilendo all’art.2 c.2 che “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione“.
Se pensiamo che nell’arco di tempo intercorso fra le due norme il parco auto degli italiani è passato da 9 milioni di autovetture a 27 milioni, riusciamo a trovare il nesso fra il bisogno sociale e le azioni del legislatore e al contempo constatare che i 60 milioni di abitanti, che in Italia oggi vogliono parcheggiare sotto casa i loro 41 milioni veicoli, rappresentano una potenziale causa di malessere per Pinco.
I fatti dimostrano che alla spinta del mercato automobilistico che dal 1989 ad oggi ha fatto si che si passasse da 1 auto ogni 6 abitanti ad 1 auto ogni 1,5 abitanti, non è corrisposto né un intervento del legislatore commisurato, né una presa di posizione da parte dei cittadini volta ad affrontare e risolvere il problema.
Il timore è che, come cittadini, per il fatto di corrispondere un tributo finalizzato all’organizzazione di un servizio ci si senta sollevati da ogni responsabilità inerente il servizio stesso incluse eventuali proposte per il suo miglioramento o la sua efficienza, e ci si limiti a rivendicare diritti “sull’ombra proiettata dal proprio albero” al manifestarsi del bisogno.
D’altro canto il legislatore ha preso atto che l’introduzione di nuove norme avrebbe senso se quelle vigenti fossero oggi nella consuetudine…e così non è.
La provocazione “parcheggiare dove c’è posto e spazzare di fronte a casa” vuole sottendere una presa di posizione possibile, e non quella più comoda, e ipotizzare azioni alla nostra portata da cui possa scaturire una regola sociale di crescita sostenibile.
Per meglio spiegare cosa si intenda si pensi all’uso della pietra raccolta nel sito in cui venivano realizzati gli immobili e lo si raffronti con l’impiego in tempi più recenti, di materiali di larga diffusione a minor costo per cui si è creduto di poter trascurare la ricerca di relazioni con il contesto.
Gli studi dimostrano che dal primo atteggiamento è derivato un duplice processo di artificializzazione della natura e di naturalizzazione degli ambiti costruiti (Atzeni, 2009), addivenendo al soddisfacimento del bisogno attraverso l’indagine dell’attitudine del luogo.
Dell’importanza di questa ricerca si è capita la valenza nel momento in cui è mancata nel secondo atteggiamento, rivelando la sua utilità nel conferire identità ai luoghi e nell’infondere un senso di appartenenza endogeno.
Analogo discorso potrebbe essere fatto in relazione al disegno sociale, di cui si è parlato in precedenza, che attraverso le norme ha configurato una nuova idea di spazio pubblico urbano. Fino a quel momento il villaggio sardo tradizionale non prevedeva spazi pubblici. Si potevano individuare fulcri dell’urbano e dei quartieri, identificabili comunemente in luoghi di culto o fontane, che essendo attrattivi in relazione alla loro funzione, generavano occasioni di relazione fuori dal perimetro domestico, ma lontani dal potersi definire piazze.
Se infatti per assurdo provassimo a immaginare la trasparenza dei muri di confine su strada dei cortili del centro storico, si manifesterebbero a noi tanti luoghi che nell’accezione attuale verrebbero definiti “piazza”, o se ci soffermassimo a riflettere sul termine pratha vedremo che in diversi dialetti sardi definisce sia il cortile domestico che il luogo pubblico e collettivo.
Il termine pratha dunque, originariamente riferito ai cortili privati, ha assunto poi, in relazione ai nuovi indirizzi sociali, il significato di spazio pubblico come oggi inteso.
Il fatto che l’attualità dia atto di centri storici degradati e di una diffusa percezione bipolare dello spazio pubblico, per cui a seconda delle circostanza se ne rivendica titolo esclusivo o gli si attribuisce competenza pubblica, fa ipotizzare che la scrittura del disegno sociale non sia stata adeguata o perlomeno tale non è stata percepita e che sarebbe opportuno pensarne una nuova che magari istituzionalizzi un impegno diretto dei cittadini negli aspetti pubblici di prossimità al fine di tener sempre viva la ricerca di un legame stimolante e far si che il pazzo di paese del film “NUOVO CINEMA PARADISO” urli “la piazza è mia” volendo dire è nostra.
Miriam Cossu, Architetta
Per approfondire:
G. Ortu, A. Sanna (a cura di) Atlante delle culture costruttive in Sardegna, ITACA – Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali