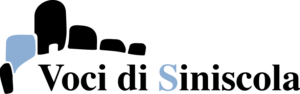L’Arte, l’Artista e la Forza Indistruttibile di una Donna
Oggi vi porto a fare un viaggio nel tempo, nell’arte e nelle intricate pieghe dell’animo umano, prendendo spunto da una storia affascinante e al contempo dolorosa: quella di Costanza Piccolomini Bonarelli, magistralmente rievocata da Luisa Pronzato, una giornalista del “Corriere della Sera” che ci ha lasciato troppo presto, ma il cui spirito libero e la cui profonda umanità continuano a brillare attraverso i suoi scritti.
La storia di Costanza ci offre un’opportunità straordinaria per riflettere su un tema cruciale: il valore intrinseco dell’arte, la distinzione tra l’artista e la sua opera, e il ruolo del lettore o dello spettatore nel conoscere senza giudicare.
Costanza Piccolomini Bonarelli, come ci racconta la Pronzato, non è solo una musa, una figura silente immortalata nel marmo.
È una donna viva, tenace, colta, intelligente, e straordinariamente libera per la sua epoca.
La sua vita, segnata da nobili origini ma anche da difficoltà economiche, la porta a Roma dove sposa Matteo Bonarelli, scultore e mercante d’arte. È lì che incrocia il cammino di Gian Lorenzo Bernini, il genio indiscusso del Barocco, l’uomo che ha plasmato Roma e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte.
Bernini, follemente innamorato di Costanza, le dedica un ritratto in marmo che non ha eguali. Un’opera senza committente, nata da un’esigenza intima, un capolavoro di sensualità e realismo che ancora oggi ci lascia senza fiato. Come descritto, la camicia aperta sul seno, i capelli scomposti, le labbra socchiuse in un sospiro: è l’incarnazione della vita, della passione, un “unicum della ritrattistica femminile di Bernini”. Quest’opera ci parla di un amore, di un desiderio, e del potere dell’arte di catturare l’effimero e renderlo eterno.
Ma la storia di Costanza non è solo quella di un amore passionale e di un ritratto sublime. È una storia che si tinge di oscurità quando Bernini scopre la relazione di Costanza con suo fratello Luigi. La passione si trasforma in violenza. Bernini, aggredisce il fratello e, in un atto di brutalità inaudita, fa sfregiare Costanza con un rasoio. La donna, vittima di questa violenza disumana, viene addirittura accusata di adulterio e rinchiusa in un monastero, mentre Bernini, l’uomo potente e celebrato “Huomo raro, ingegno sublime”, la fa franca, protetto dal Papa stesso.
Ed è qui che si aprono le domande fondamentali: come conciliare la grandezza dell’artista con la sua efferata violenza? Dobbiamo condannare l’opera a causa delle azioni dell’artista?
La risposta che ci offre la storia di Costanza, e l’approccio che dovremmo adottare, è che il valore dell’arte è intrinseco all’opera stessa e va distinto dalla moralità dell’artista.
Bernini, l’uomo, è stato capace di una violenza indicibile, di un gesto “atroce”, come lo definisce Montanari. Ma Bernini, l’artista, ha creato capolavori che hanno letteralmente “cambiato il mondo con l’arte”.
Il busto di Costanza, la fontana dei Quattro Fiumi, il Baldacchino di San Pietro: queste opere sono espressione di un genio creativo che trascende il comportamento personale del loro autore. Negare il valore di queste opere significherebbe impoverire il patrimonio culturale dell’umanità, perdere la possibilità di ammirare la bellezza e la maestria che esse racchiudono.
E qui entra in gioco il ruolo del lettore, del pubblico, di noi tutti. Dobbiamo conoscere la storia nella sua interezza, senza edulcorazioni. Dobbiamo essere consapevoli che dietro a un’opera d’arte possono celarsi storie complesse, a volte dolorose, a volte scomode. Ma conoscere non significa giudicare in modo superficiale o, peggio ancora, cadere nella trappola della “cancel culture” che, come suggerisce la Pronzato, rischia di cancellare l’opera insieme all’uomo.
Come evidenEike Schmidtzia la mostra degli Uffizi che ha accostato il busto di Costanza alle foto di donne sfregiate dall’acido, l’arte, anche quella nata da contesti difficili, può diventare un potente strumento di riflessione. Può aiutarci a “meditare sul dolore inenarrabile della sopravvivenza”, come ha spiegato il direttore Eike Schmidt.
La storia di Costanza, dopotutto, non si conclude con la sua prigionia.
Lei esce dal monastero, “restituita al marito”, un uomo che, pur non essendo un genio dell’arte, si rivela più umano di Bernini. Costanza si reinventa, diventa imprenditrice, prosegue l’attività del marito, e cresce una figlia, un segno di vita e di resilienza. La sua è la storia di una donna che, nonostante gli sfregi e la dannazione, rimane “incancellabile”, un’eroina di forza e libertà.
In conclusione, l’arte è un linguaggio universale che ci parla attraverso i secoli.
Essa è frutto di un genio, a volte tormentato, a volte eticamente discutibile, ma il valore dell’opera risiede nella sua capacità di emozionare, di far riflettere, di innalzare lo spirito umano.
Il nostro compito non è quello di censurare il passato o di giudicare gli artisti con la lente della nostra moralità contemporanea, ma piuttosto di conoscere la complessità delle storie, di distinguere l’opera dall’autore, e di apprezzare la bellezza e il significato che l’arte continua a donarci, anche quando ci mette di fronte alle pieghe più oscure dell’animo umano.
Simonetta Bellu