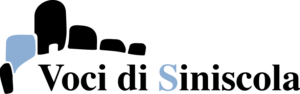In occasione della Giornata della legalità 2025 tenuta dall’ITCG “Luigi Oggiano” una delle tappe del percorso era davanti al ritratto di questo famoso personaggio di Siniscola, che ha onorato sia la sua professione di avvocato, sia il suo impegno di politico.
Pubblichiamo la riflessione su Oggiano e la legalità, tenuta dal Prof. Antonello Pipere, docente dello stesso Istituto e Presidente del “Centro Studi Luigi Oggiano” di Siniscola.
LUIGI OGGIANO E “LA BASE MORALE”
Parlare di Oggiano in una giornata sulla legalità significa mettere in evidenza il valore esemplare di un’esistenza. Più che gli scritti la vita stessa di Oggiano come si è svolta negli anni costituisce un esempio ideale e un riferimento attualissimo.
Per altri versi ci sono alcune pregnanti informazioni che ci provengono dai pochi scritti e soprattutto dagli interventi parlamentari. Oggiano “non era uno scrittore” come amava definirsi con sottile riferimento all’amico Emilio Lussu. Visse in modo riservato. Per il suo equilibrio e le sue apprezzate relazioni congressuali fu sempre indicato nel suo partito per esprimere risposte moderate, per interventi dove era necessaria la condivisione e la moderazione e che trovavano sempre un consenso unanime.
Sapeva che le divisioni potevano lacerare e impedire l’azione politica, che invece aveva sempre bisogno di unione e di coesione.

Il dipinto di Salvatore Russo, nell’atrio dell’Istituto Tecnico a cui è intitolata la scuola racchiude la sintesi di una vita e di un pensiero politico e ideale. Oggiano viene raffigurato da giovane e da adulto con la bandiera sarda al centro e soprattutto risalta il concetto di autonomia riportato centralmente nelle parole in basso.
L’autonomia è intelligenza, consapevolezza dei diritti e rispetto dei doveri: è sicuramente questa la chiave per capire il senso della legalità e dell’autonomia nelle quali Oggiano si era riconosciuto nel corso degli anni, in una dimensione che univa la sfera politica e quella personale.
L’autonomia è un concetto che viene dai primi ideologi del sardismo (Pilia, Orano, Bellieni), ma ha dei precedenti illustri nel Risorgimento italiano, in Cattaneo, in Mazzini, infine in Tuveri e Asproni.
Si sviluppa attraverso lo stato federale, democratico e repubblicano, con il riconoscimento e il ruolo degli enti locali, specialmente nei comuni, dove bisognava amministrare con criteri di equità e con un profondo senso di equilibrio e di giustizia a favore dei cittadini. In assenza di questi principi si sarebbe generata la sfiducia nelle istituzioni e nello stato.
Da una corretta ed equa amministrazione poteva derivare un senso di giustizia diffuso e dunque il rispetto della legalità che implicava anche il riconoscimento dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L’autonomia era intesa come una responsabilità dei singoli, delle istituzioni, di uno stato che immaginava con una struttura federale articolata, dove la Sardegna aveva un suo statuto con maggiori poteri rispetto a quello approvato nel secondo dopoguerra.
Si trattava di una conquista ideale del pensiero sardista e autonomista che ritroviamo non solo in Camillo Bellieni, Francesco Fancello, Titino Melis, ma anche in Emilio Lussu e Pietro Mastino.

Per altri versi tutta la vita di Oggiano è in fondo basata sull’esaltazione e sul rispetto della legge, come dimostra anche quel continuo ricorso al codice durante il lavoro di avvocato insieme ai giovani discenti ai quali raccomandava di evitare gli sprechi inutili (Garippa, 2017).
In una nota intervista a Antonello Satta (1974) Oggiano sosteneva di essere considerato un uomo d’ordine, da intendere come un uomo delle istituzioni, ossequioso delle regole e del diritto. In questo senso effettivamente Oggiano credeva fermamente nello stato di diritto, ossia in uno stato repubblicano, democratico garantista, fondato sulla tripartizione dei poteri e retto su un profondo equilibrio tra organismi e istituzioni. Una condizione che era alla base della convivenza democratica e civile.
Senza questa idea di stato condivisa non poteva esserci rispetto di regole e pertanto poteva generare la diffidenza e azioni di illegalità da parte del cittadino. La sfiducia verso lo stato poteva nascere anche nella promulgazione di leggi poco chiare, difficilmente interpretabili o che non garantivano operativamente la loro corretta applicazione.
Come era illegale secondo Oggiano il processo sommario, che non offriva garanzie, il diritto preventivo alla difesa dell’imputato. In questo senso Oggiano era un garantista, come si direbbe oggi, nel senso che doveva essere conferita a tutti la possibilità di difendersi e di avere il diritto alla tutela legale e a un’istruttoria processuale.
Oggiano affermava anche di essere “contrario alla demagogia”, a una falsa idea di democrazia, come potrebbe essere oggi il populismo, la retorica vuota, l’autopromozione, la propaganda vacua e fine a se stessa. L’uomo di governo secondo l’intellettuale deve affrontare i problemi sociali con lo studio, con l’analisi meticolosa dei problemi evidenziandone i diversi risvolti e i differenti punti di osservazione e soprattutto indicando una visione e un’azione politica chiara, forte di una visione e di una motivazione morale, o “base morale”, come la definiva, intesa con accenti non dissimili dalla “questione morale” espressa da Enrico Berlinguer negli anni Settanta di fronte al degrado morale dei partiti e al clima di corruzione di quegli anni.
Per Oggiano la base morale era un punto di osservazione necessario quando si affrontavano i problemi politici e sociali. In questa osservazione attenta dei problemi sociali era richiesto l’approccio tecnico-giuridico, quello economico-finanziario, quello politico ovviamente. Ma l’atteggiamento morale del politico era una condizione necessaria, come un principio orientativo sulle scelte di governo, come nel caso delle pensioni di guerra per gli ex combattenti o per i mutilati, per i quali era un “atto morale” prima che economico garantire necessariamente un sussidio finanziario dignitoso.

In questo Oggiano è stato un esempio di legalità, di equilibrio. La vita a favore dell’avvocatura, non l’avvocatura come lavoro e realizzazione personale e tanto meno come occasione di contatti clientelari utilizzabili politicamente; ma come ruolo da svolgere con senso etico, e l’etica, cioè la “base morale”, come sosteneva, doveva essere anche alla base dell’azione politica.
In questo senso l’azione professionale condotta ordinariamente nel foro di Nuoro e attraverso le preture della provincia era un tutt’uno con l’attività politica. L’una e l’altra erano indirizzate verso un unico fine di elevazione sociale dei cittadini sardi.
L’azione politica doveva andare verso la soluzione dei bisogni sociali, per assicurare il diritto ai trasporti e a tribunali efficienti, alle scuole, a uno sviluppo agricolo e industriale in linea con quanto si stava verificando nelle regioni più progredite del Paese.
La legalità si poteva applicare rispettando le persone, le loro attitudini culturali. In questo senso l’illegalità e la delinquenza non erano originate da condizioni genetiche, da fattori razziali (Niceforo, Orano), ma nasceva dall’ingiustizia sociale, dai bisogni primari non soddisfatti e da uno stato ingiusto e poco sensibile. In questo senso, insieme a quei brillanti avvocati del foro di Nuoro il Senatore capiva che il mondo contadino e pastorale sardo aveva una propria secolare concezione della giustizia, come aveva più tardi teorizzato Antonio Pigliaru (1959).
Legalità significava avere il diritto a una pensione da reduce di guerra, ma anche restituirla o “rimandarla al mittente” quando era stato compiuto un servizio pubblico temporaneo come quello parlamentare.
Giustizia e legalità erano valori che si manifestavano quotidianamente nel lavoro dello studio di Via Dante a Nuoro, dove favoriva il viaggio di ritorno da Nuoro o che difendeva talvolta anche gratuitamente, o con “parcelle risicate al minimo”. Da un’esigenza di legalità derivava il profondo interesse per il mondo agricolo della sua Baronia e del Nuorese, per promuovere lo sviluppo di un territorio sottosviluppato, dove bisognava studiare a fondo i problemi e insegnare a diffondere nuove idee e favorire nuove proposte di formazione per la crescita e la ricerca di condizioni di lavoro e di vita migliore.
Ecco questi aspetti costituiscono ancora oggi l’insegnamento più valido e in fondo il messaggio ancora attualissimo dell’uomo a cui è intitolato l’Istituto Tecnico di Siniscola.
Diffidava della demagogia, degli estremismi ideologici, della falsa democrazia e del “frastuono delle parole”. Al centro della sua attenzione c’era la Sardegna, un mondo di umili, che aveva vissuto un’ingiustizia secolare, che aveva diritto al riscatto storico, che aveva conosciuto direttamente dall’infanzia e infine nei suoi solitari trasferimenti da una pretura all’altra, nell’impegno politico e professionale.
Antonello Pipere
Per approfondire:
Centro Studi Luigi Oggiano
Casa Museo Luigi Oggiano, via XI Febbraio, 08029 Siniscola
Luigi Oggianu, storia di un uomo perbene