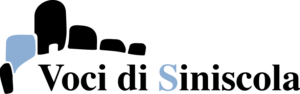“Di madre in figlia” di Concita De Gregorio
Se mi guardo indietro è impossibile immaginare la mia vita senza libri.
La nostra casa, grazie a mia madre, è sempre stata abitata non solo da noi ma anche dai classici della sua infanzia e adolescenza.
Una piccola stanza che, ai tempi, non era ancora la mia, era riservata esclusivamente alle enciclopedie, ai dizionari, alle opere di Grazia Deledda e alla letteratura per ragazzi.
Quella di cui io non potevo proprio fare a meno.
Ricordo, ancora oggi, le prime immersioni in storie fantastiche che non erano le mie ma che, in qualche modo, lo diventavano.
Era pura magia. Un tempo esclusivamente mio.
Uno spazio a cui solo io potevo accedere, attraverso la mia immaginazione di bambino.
Mio padre, invece, si teneva lontano dai libri ma non dalla musica di cui è sempre stato un grande cultore.
Qualcosa mi è arrivata anche da lui e questi due mondi non sono mai stati antitetici l’uno con l’altro, anzi sono andati di pari passo.
Non è raro che, leggendo un libro, una canzone in particolare si fermi dentro la mia testa, richiamandone il suo contenuto.
Per molti potrebbe essere disturbante. Io, invece, lo percepisco come un vero e proprio accompagnamento.
In “Di madre in figlia”, l’ultimo romanzo di Concita De Gregorio edito da Feltrinelli, la colonna sonora – quella che la mia testa mi ha suggerito – è stata “Amare di meno” di Erica Mou, cantautrice di Bisceglie. La canzone è contenuta nell’album “Bandiera sulla luna“, del 2017. Il verso che mi ripetevo, ogni tanto, durante la lettura era: “sarebbe così bello amare di meno ma farlo meglio”.
E su quel meno andava tutta la mia attenzione. Perché questa è un’opera in cui l’autrice si concentra totalmente sul valore della misura.
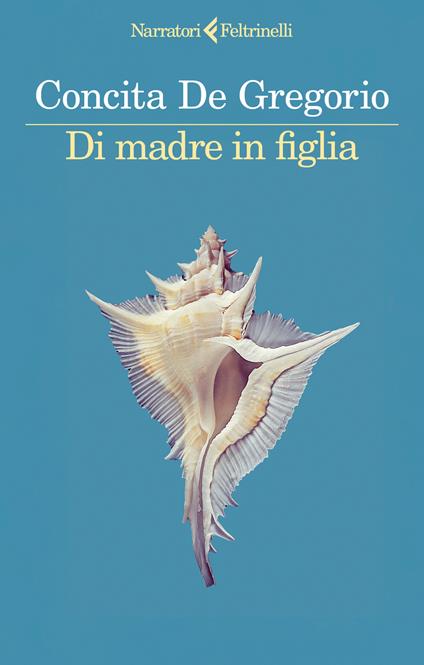
Come amiamo è importante ma lo è anche quanto amiamo.
Perché la dose di un amore, esattamente come quella di un farmaco, non deve e non può essere eccessiva.
Se lo fosse, come in un rapporto tra madre e figlia, diventerebbe un veleno. Finirebbe per non salvare nessuna delle due parti ma per soffocarle entrambe.
Farmaco deriva dal greco pharmakon e ha un duplice e antitetico significato: rimedio, medicina ma anche veleno.
I figli passano attraverso il corpo delle madri ma ledere, in qualsiasi modo, la libertà dell’altro non può che essere nocivo.
L’autrice mette in rilievo un quadro generazionale di donne (Agata, Marilù, Angela, Adè) legate sì dal sangue ma con un sentire differente. Rispettivamente sono la bisnonna, la nonna, la madre e la figlia. Ognuna, a eccezione dell’ultima, è stata madre a modo suo.
Marilù, ad esempio, ha mantenuto la propria indipendenza, dedicandosi a se stessa.
Angela, sua figlia, l’ha percepita come trascuratezza, la sua.
Si è sentita messa da parte, non considerata per cui una volta diventata la madre di Adé diventa eccessivamente presente e iperprotettiva. Non consente nemmeno a se stessa di dire che le manca perché lo considera un atto profondamente egoistico.
Il punto è che i genitori possono proteggere i propri figli ma non possono pretendere, e tanto meno determinare, la loro felicità, poiché questo è un lavoro esclusivamente individuale.
I figli, a loro volta, non possono rendere felici i genitori per cui devono liberarsi di questo inutile fardello.
Questa è la storia di quattro donne che rappresentano un modo di vivere comune; un genitore che nutre nei loro riguardi un’aspettativa destinata a essere disattesa.
Un figlio o una figlia non devono sentirsi responsabili di questo: per aver tradito un’ambizione altrui. L’amore qui non c’entra e nemmeno la felicità.
Amare significa saper dosare il proprio sentire, lasciando all’altro la libertà e la possibilità di essere chi è.
In questo caso l’amore è un farmaco capace di curare e che contiene, senza trattenere.
Solo questo conta. E solo questo serve.
La scrittura di Concita, in questo romanzo, è un fiume.
Le parole non scorrono e basta, sono velocissime e si ha come la sensazione che siano davvero troppe.
Ciò è dovuto sicuramente alla volontà della scrittrice, per sottolineare che i gesti conterebbero decisamente di più. Eppure, ci affidiamo alle parole più che al silenzio dell’atto in sé.
Parlare di madri non è semplice, si tratta di una bella responsabilità e Concita, come hanno fatto Elsa Morante e Elena Ferrante, ha portato alla luce uno dei temi più delicati che esistano nella nostra letteratura.
Un argomento che assume diverse sfaccettature e che, in quest’opera, si presenta come un tema profondo e da scandagliare ulteriormente.
Luigi Serra