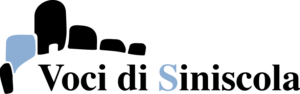RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEL PRESENTE, a cura di Ruggero Roggio
Quale destino per la democrazia?
L’Oxford Internet Institute ha rilevato che in 48 paesi nel 2012 ci sono state campagne politiche di manipolazione dei social media. Miliardari e governi ne sono stati finanziatori. Robert Mercer, un miliardario americano molto vicino a Trump, ha finanziato Cambridge Analytica, una azienda specializzata in questo tipo di manipolazioni che ha avuto un ruolo attivo nella campagna elettorale di Trump e in quella per la Brexit (Crouch 2020).
I dati per profilare le persone erano stati presi da Facebook (Stefano Bartolini, Ecologia della felicità. Perché vivere meglio aiuta il Pianeta, Aboca, p.171). Se pensassimo all’opposizione al Green deal ed al negazionismo del cambiamento climatico (in questa circostanza le politiche o sono globali o non sono efficaci), alla costruzione di meccanismi di sfiducia conflittuali (Covid), constateremo una costruzione strutturata di sfiducia verso le politiche democratiche.
Rileva Diego Gambetta: “Una volta che la sfiducia si è insediata, diventa ben presto impossibile sapere se era giustificata in partenza, perché manifesta la capacità di auto avverarsi, di generare una realtà coerente” (D.Gambetta, Possiamo fidarci della fiducia?,p.305, in Le strategie della fiducia. Indagini sulla razionalità della cooperazione, Einaudi, 1989).
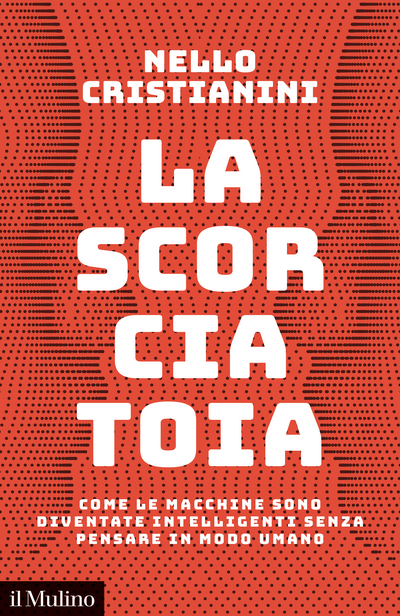
Il gioco della persuasione e della manipolazione elettorali ha preso piede ed è ormai ricco di modalità collaudate.
“Gli psicologi conoscono vari biases cognitivi, come l’effetto framing per cui le decisioni di un soggetto dipendono da come la scelta viene presentata piuttosto che dalle sue conseguenze: abbiamo visto come l’economia comportamentale faccia uso di questo bias cognitivo per indirizzare le scelte dei consumatori, e come gli agenti di raccomandazione siano talvolta progettati per imparare più automaticamente quale presentazione sia più efficace nell’indirizzarli” (in N.Crisantini, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, il Mulino, 2023, p.157).
Ogni manifesto dell’Intelligenza artificiale ha premessa di tutele e democraticità, quasi una excusatio non petita, accusatio manifesta.
Io diffido.
La dichiarazione di indipendenza del 1776 degli Stati Uniti includeva, tra i diritti inalienabili dell’uomo, il perseguimento della felicità. Affermazione di principio, che non ha impedito il genocidio delle Nazioni indiane (e le riserve non dissimili dai campi di concentramento), né una Guerra Civile (1861-1865) dove lo schiavismo era uno dei motivi del conflitto. Paradossale questa frase “[…] e Phil White gli chiese se non si vergognava di portare via i negri di una povera donna, che erano tutta la sua ricchezza” (A.Barbero, Alabama, Sellerio p.202).
Perché la felicità non è per tutti, si può anche uccidere per avere la propria.
Possiamo immaginarci neoluddisti contro la IA?
Pensare ingenuamente a poter comunque staccare la spina (lo diceva Obama) come ultima ratio?
Buttare via il bambino con l’acqua sporca?
C’è un romanzo di Ian McEwan – Macchine come me, Einaudi, 2019 – bellissimo, ucronico (la réunion dei Beatles, Alan Touring in vita) in un mondo dove androidi super intelligenti sono al servizio di chi li acquista. Evito ogni spoiler ma riporto una frase: “La mia speranza è che un giorno quello che lei ha fatto ad Adam con il martello sia considerato un crimine a tutti gli effetti. È forse perché lo ha pagato? Per questo pensava di averne diritto? (p.278)”. A parlare è Alan Turing, matematico inglese, che negli anni 50 del secolo scorso ideò il test omonimo, in base al quale l’intelligenza artificiale sarà operativa quando in una comunicazione tra uomo e macchina sarà indistinguibile dalla IA.
Kurzweil lo dà per certo al 2029.
Ci siamo. Ma il futuro gioca d’anticipo. “Più robot che umani: il sorpasso di Amazon” (in La Repubblica del 2.7.2025) è il titolo di un servizio di Massimo Basile secondo cui il 75% delle consegne vede la partecipazione di robot. Di spalla un commento di Massimo Adinolfi – Attenzione sono bracci e non braccia (ibidem, La Repubblica, cit.): “Ovviamente non c’è una risposta precisa, ma si può suggerire l’idea che è pur sempre la comunità umana – la sua cultura, il suo linguaggio e la sua storia a decidere quale dignità dare al robot (mero mezzo meccanico: bracci) e all’uomo o alla donna (essere vivente, razionale o bipede implume che sia, comunque una cosa diversa, per cui: braccia)”.
Chiudo questa rassegna bibliografica con una citazione tratta da The game, il libro che Alessandro Baricco (Einaudi, 2018) dedica al mondo virtuale:
“Siamo divinità festive, che creano nel settimo giorno, quello in cui il dio vero riposa” (p.45).
Ruggero Roggio
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEL PRESENTE, a cura di Ruggero Roggio